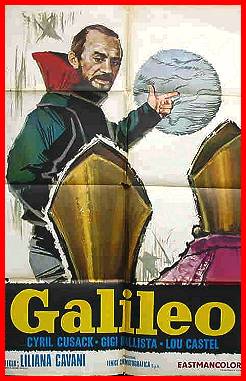I
volti bianchissimi, come nella morte, le labbra che pur nel bianco e nero o nel
seppia si indovinano in qualche modo vermiglie, perché è solo e tutto lì che si
è raggrumato il sangue che ci fa vivi. E, ancora, gli occhi cerchiati tutt’attorno di
nero, i capelli scomposti, corvini o bianchissimi, lo sguardo oltrepassante,
tipico della follia in certe sue manifestazioni, il passo lento, solenne,
cadenzato o a piccoli movimenti rapidi, in una specie di corsa grottesca e innaturale. E poi quella specie di “ebetudine
stuporosa” degli occhi dilatati e di una sorta di stato catatonico, descritta
dall’antropologia come difesa utilizzata per non essere
catturati, perché così, immobili, fingendoci di pietra o già morti, nessun mostro predatore si
impossessi di noi.

Come nel mondo della follia, infatti, nel film gli esseri
umani si fanno cose, ma viceversa le cose sembrano animizzarsi, avere poteri umani, persino
parlare. Il pavimento sghimbescio pare quasi spostarsi sotto i piedi, il soffitto
abbassarsi, le pareti restringersi, le porte dilatarsi e spalancarsi come bocche
sgangherate e terribili. Sono dipinti d'arte i fondali del film e la telecamera è fissa, come un occhio enorme, dilatato e immobile spalancato sull'infinito.
E’
stato un godimento totale, ieri sera, guardare su grande schermo la copia
restaurata alcuni anni fa de “Il gabinetto del dottor Caligari”, per di più con
la musica dal vivo. Un po’, personalmente, perché mi faceva pensare
all’amatissimo “Nosferatu” di Marnau, successivo di soli due anni, ma anche alle
lunghe mani di ragno, alla loro danza elegante e agli occhi cerchiati nel
pallore del volto di Klaus Kinski, nei panni dell’altrettanto amato e più moderno e malinconico Nosferatu messo in scena da Herzog.
Un po’ perché questo film racconta di tutte le questioni centrali sulle quali si interroga la filosofia, quella vera,
fin dalle sue origini, a partire dalla domanda delle domande: se davvero questo
tavolo che tocco o questo computer su cui sto digitando i miei pensieri, per
renderli materiali e fermarli, siano più reali di quei pensieri stessi lasciati
liberi o dei miei desideri, dei miei sogni, del mio fantasticare felicità
possibili, delle mie paure e dei miei incubi.

C’è una realtà impalpabile,
inafferrabile, ma profondissima, che prende nomi diversi a seconda del proprio
sguardo sul mondo. In religione viene chiamata “anima”, ma io ne rivendico la
natura indipendente e laica: è il nostro mondo interno, ma anche la nostra rete
di affetti. Non si afferrano l’amore o la paura, eppure danno spessore e senso
all’esistenza. Non si afferra il desiderio, non si afferrano i sogni che
popolano le nostre notti e allo stesso modo non si afferrano i ricordi o il
passato , eppure esistono e sono reali, sebbene fatti di un’altra stoffa rispetto
a quella dei nostri abiti, con i quali ci nascondiamo o mascheriamo per il
mondo. Sono la nostra storia, la nostra identità stessa.

Ecco: forse è questo che mette in scena il film, la
nostra nudità emotiva. Una nudità che ci sgomenta e atterrisce perché rende
meno significativo il confine tra il mondo della normalità, che si autodichiara
tale, e il mondo della follia. Quando il dottore dei matti viene trattato come
un matto, mentre si dimena disperato prigioniero dello strumento di tortura che
in quegli anni segnava una distanza, data dal potere, tra chi rinchiude e
segrega in un’altra realtà e chi vi è rinchiuso e segregato, noi siamo come
ipnotizzati dal biancore.
E ci accorgiamo, allora, che i camici degli psichiatri e la camicia di
forza dei pazzi hanno lo stesso colore: il bianco che annulla fantasia, sogni,
deformazioni creative e colorate della nostra realtà; tutto ciò, insomma, che non ci fa sembrare
scontato più niente e ci invita a pensare e a sentire con altri occhi.